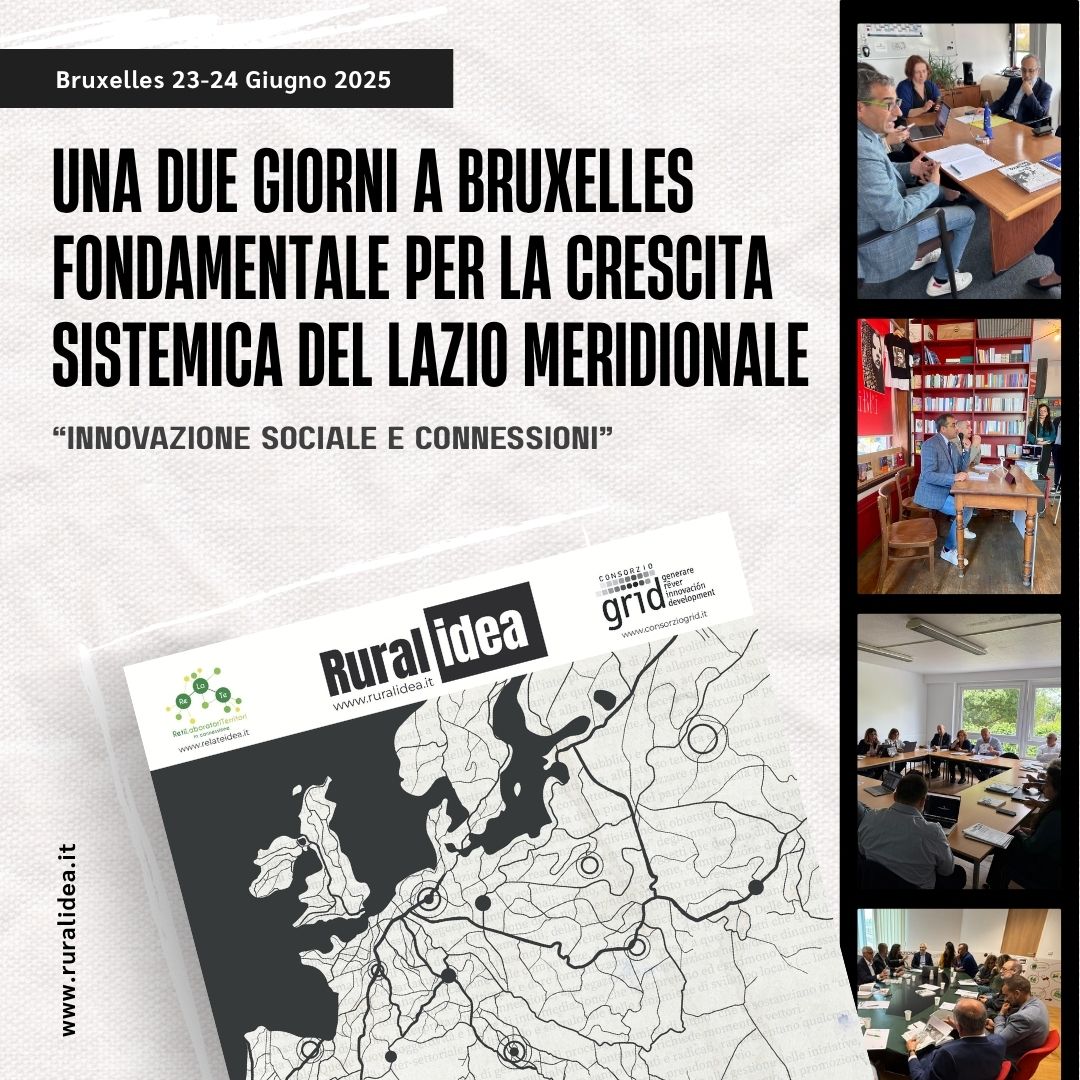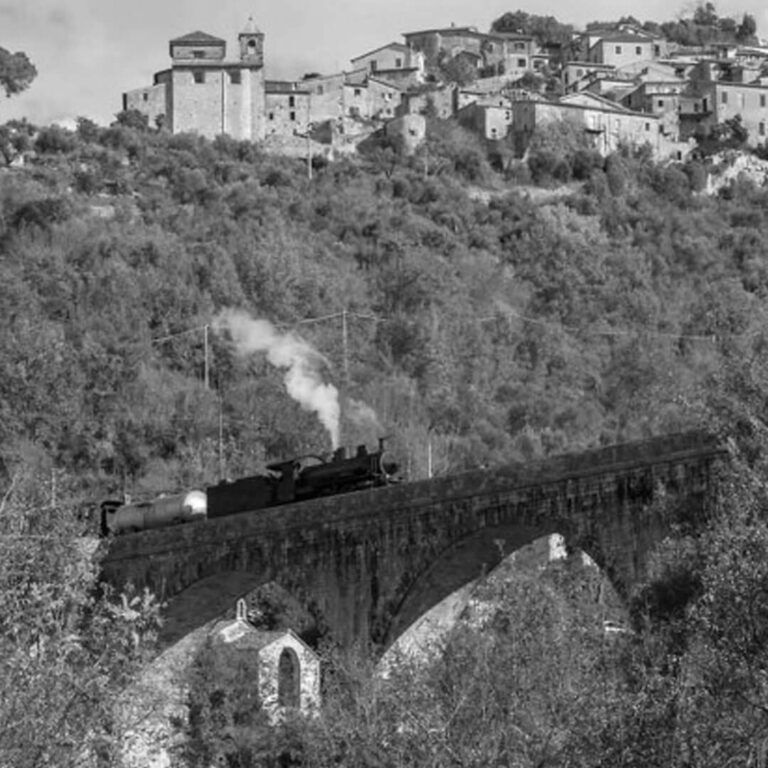La presenza di pratiche irregolari nel reclutamento e nella gestione del lavoro in alcuni settori dell’agricoltura italiana è un fenomeno che è ormai da anni portato all’attenzione della politica e del grande pubblico e sul quale insistono forti sollecitazioni ad una azione di prevenzione e di contrasto. Non sorprende infatti che, nelle raccomandazioni all’Italia per la formulazione del Piano Strategico Nazionale nel quadro della riforma della Politica Agricola Comune, la Commissione Europea inviti il nostro paese a “rafforzare gli sforzi per promuovere l’inclusione sociale nelle zone rurali, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e in particolare alla situazione critica dei migranti e allo sfruttamento della manodopera in agricoltura” (Commissione Europea 2020).
L’efficacia delle azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità nel mercato del lavoro agricolo dipende però dalle ragioni e dalle condizioni che determinano tale fenomeno e la sua diffusione nel tessuto produttivo. In particolare, ci si deve chiedere se e quanto il ricorso a pratiche irregolari nel reclutamento e nella gestione del lavoro sia riconducibile a particolari condizioni economiche del processo produttivo ed a costi del lavoro non altrimenti sostenibili negli attuali vincoli di mercato o, al contrario, sia da attribuire a circostanze sociali, culturali ed ambientali che esulano la sfera puramente economica. In altre parole, si tratta di valutare quanto sia rilevante il trade-off tra la sostenibilità economica e quella sociale di determinate attività agricole e quanto il ricorso a pratiche irregolari si riveli come una condizione di sopravvivenza di tali attività. In quelle circostanze nelle quali tale trade-off si riveli particolarmente stringente le politiche di settore e la politica agricola in particolare possono avere un ruolo sufficientemente incisivo ed efficace nel prevenire, piuttosto che nel contrastare, l’illegalità nel mercato del lavoro agricolo.
Secondo i dati dell’Eurispes (2018), nel 2017 circa il 25% dei lavoratori agricoli in Europa è irregolare o illegale. Tale fenomeno si declina in diverse forme di sfruttamento del lavoro in agricoltura, che vanno da forme di evasione contributiva a fenomeni con un alto grado di pericolosità sociale (come il caporalato) con differenti livelli di intensità negli Stati membri. Recentemente diversi casi di caporalato sono saliti agli onori della cronaca e sono stati oggetto di un rilevante dibattito pubblico e di reportage giornalistici. Secondo il Rapporto agromafie e caporalato dell’Osservatorio ‘Placido Rizzotto’ della Flai Cgil (Flai Cgil 2018), in Italia il business del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura è pari a 4,8 miliardi di euro, circa il 50% dei beni sequestrati o confiscati alle mafie sono terreni agricoli (30.526 su 68.194) e, in circa 80 distretti agricoli, equamente distribuiti tra Nord e Sud del Paese, si registrano condizioni di grave sfruttamento lavorativo, seppure con diversi livelli di intensità.
Alla luce di tale quadro, emerge chiaramente come il contrasto al lavoro irregolare rappresenti una sfida che l’Italia deve affrontare al fine di migliorare gli standard di trasparenza e legalità di un intero settore economico e dell’azione amministrativa degli enti centrali e locali coinvolti, rafforzandone la capacità di prevenire e respingere i fenomeni di illegalità, corruzione e infiltrazione criminale. È tuttavia evidente come le misure di controllo, sanzione e contenimento da sole non bastino se non si interviene sulle cause del problema e, in particolare, sui motivi che spingono le imprese ad acquisire lavoro irregolare e usufruire del caporalato. Tra le maggiori cause della diffusione del fenomeno in agricoltura: il carattere stagionale di alcuni impieghi; l’inefficacia dei canali di reclutamento formali; la crescente offerta di lavoro da parte dei migranti spesso in condizioni di irregolarità nel nostro territorio; la crisi economica e la conseguente espulsione degli stessi da altri settori produttivi; la difficoltà di talune imprese agricole a soddisfare gli oneri burocratici, contributivi ed assicurativi connessi al rispetto delle norme. Tutto ciò fa sì che, a rapporti di scambio strutturalmente sfavorevoli, si reagisca cercando di ridurre i costi legati alla manodopera.
Un recente lavoro (Sorrentino et al., 2021) ha cercato di investigare sulle cause del fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura attraverso un’analisi dei costi di produzione e dei risultati economici per la coltura del pomodoro da industria nella provincia di Foggia, traendo delle indicazioni rilevanti che possono riguardare l’intero settore orticolo. La prima e generale indicazione che scaturisce dall’analisi effettuata è quella di un sostanziale equilibrio tra il valore della produzione ed i costi espliciti ed impliciti mediamente sostenuti nel processo produttivo del pomodoro da industria. Ciò vale soprattutto se le operazioni colturali, come avviene nella grandissima parte del campione esaminato, vengono effettuate in forma meccanizzata. La seconda indicazione deriva proprio dal ruolo decisivo svolto dalla meccanizzazione che, se da un lato permette risultati economici migliori ed una minor dipendenza dal costo del lavoro, dall’altro, comporta un’acutizzazione del trade-off tra la sostenibilità economica e quella ambientale e sociale della coltura. La coltura del pomodoro da industria, come gran parte delle orticole, richiede elevati fabbisogni di lavoro soprattutto per le operazioni di trapianto e raccolta. La meccanizzazione, tuttavia, permette di ridurre di quasi dieci volte questi fabbisogni di lavoro permettendo sensibili risparmi nei costi di produzione ed il conseguimento di un margine generalmente sufficiente a remunerare il capitale immobilizzato (Tabella 1). Tutto ciò fa sì che, quand’anche il costo del lavoro fosse il doppio di quanto è risultato dalla rilevazione, i suoi margini di riduzione, operando sul fabbisogno di manodopera o sul suo costo unitario, restino contenuti nel limite di qualche centinaio di euro per ettaro. Anche nelle situazioni di maggiore vulnerabilità laddove si riscontra una scarsa redditività della coltura, questa sembrerebbe ricondursi a fattori strutturali ed organizzativi dell’azienda, piuttosto che ad un elevato costo del lavoro. Queste considerazioni lasciano ritenere che la presenza nella regione di pratiche irregolari nel reclutamento e nella gestione del lavoro non sembrerebbe riconducibile ad uno squilibrio strutturale nei risultati economici della coltura quando essa è meccanizzata. Tali pratiche non appaiono pertanto indotte da necessità di sopravvivenza dell’attività produttiva nell’area presa in esame, quanto invece da condizioni ambientali e di ordine pubblico che si riflettono sull’organizzazione delle attività produttive.
Un’ultima considerazione che si evidenzia nello studio riguarda le politiche e le strategie di coordinamento della filiera ed il loro ruolo potenziale nel prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità nel reclutamento della manodopera. Nonostante la sostanziale rimozione del sostegno accoppiato, che la PAC aveva storicamente accordato alla coltura del pomodoro da industria, questa attività produttiva riesce a conseguire risultati economici mediamente accettabili nell’area in esame. Ciò grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte ed alla riorganizzazione dei processi produttivi e della commercializzazione del prodotto. In questo quadro anche l’azione delle Organizzazioni dei Produttori, promosse e cofinanziate dall’OCM, ha fornito un importante contributo. Esse hanno però operato prevalentemente a valle della produzione, offrendo servizi ai produttori essenzialmente sul fronte della concentrazione e commercializzazione del prodotto e della contrattazione con l’industria. I risultati di questo studio, tuttavia, mettono in evidenza l’opportunità di utilizzare gli strumenti dell’OCM per sviluppare l’azione delle OP anche a monte della fase produttiva nell’approvvigionamento dei fattori della produzione. Nel complesso, il ruolo strategico della meccanizzazione nel contenere il costo del lavoro, la dimensione ridotta dei lotti di produzione e la conseguente diffusione del contoterzismo suggeriscono che un più forte coordinamento della produzione organizzata nell’approvvigionamento e nella gestione dei macchinari e del lavoro potrebbe contribuire a contenere i costi di produzione. Questo potrebbe infatti consolidare i margini reddituali della coltura soprattutto in quelle realtà che, purtroppo, non raggiungono risultati economici adeguati e contribuire a disinnescare all’origine eventuali pratiche irregolari di reclutamento del lavoro.
Sulla stessa linea di ricerca, ha preso il via recentemente il progetto “Lav.Reg.La” dell’Università degli Studi della Tuscia e del CREA-PB, finanziato dalla regione Lazio. Il progetto intende fornire uno strumento di analisi a sostegno di interventi finalizzati al contrasto e alla prevenzione del lavoro irregolare nella filiera agroalimentare laziale. Attraverso l’analisi dei costi di un campione statisticamente significativo di aziende orticole laziali si pone l’obiettivo di identificare le caratteristiche strutturali, economiche ed organizzative che rendono le aziende agricole potenzialmente più esposte al ricorso a manodopera irregolare.
Riferimenti bibliografici
CGIL – FLAI (2018). “Agromafie e caporalato”. A cura dell’osservatorio Placido Rizzotto. Rapporto 04. Biblioteka Edizioni, Roma.
Commissione Europea, “Raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC dell’Italia”, SWD (2020) 396 final, Bruxelles 2020
Eurispes (2018). “Povertà, disuguaglianze e fragilità in Italia. Riflessioni per il nuovo Parlamento”, Eurispes e Universitas Mercatorum
Sorrentino A., Scardera A., Severini S. (2021). “Analisi dei costi di produzione e dei risultati economici per la coltura del pomodoro da industria nella provincia di Foggia”. Rapporto di Italia Ortofrutta per l’attuazione del progetto Fi.Le Filiera Legale finanziato a valere sull’Asse 7 – Azione 7.2.1 del PON Legalità 2014-2020.