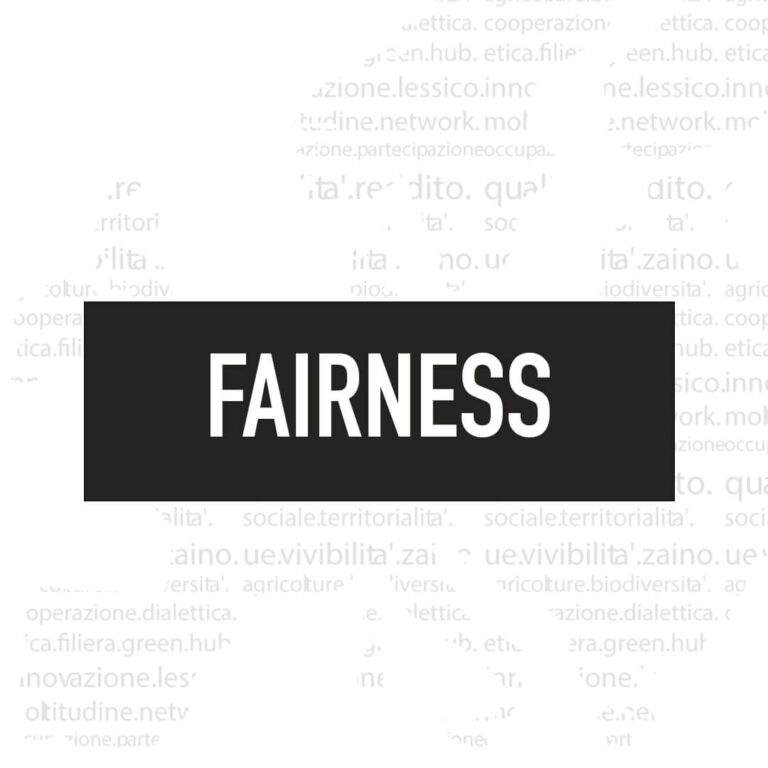L’evoluzione della PAC negli ultimi 60 anni non rappresenta unicamente la storia dello sviluppo dell’agricoltura europea ma è l’indicatore del successo dell’integrazione europea e delle sfide future. Il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, indicava esplicitamente che il “mercato comune comprende l’agricoltura e il commercio del prodotti agricoli”; di fatto la Politica Agricola può essere considerata la prima politica “comune” alla base del progetto europeo nell’Europa uscita dalla Seconda guerra mondiale. Il contesto economico e sociale dell’Europa post-bellica, in cui i Paesi non erano in grado di soddisfare la domanda interna di prodotti alimentari, mostrava l’esigenza di fondare la cooperazione economica sulla produzione agricola, in termini di aumento della produttività. Secondo il Trattato la PAC avrebbe dovuto rispondere a cinque grandi obiettivi: incrementare la produttività; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. L’impostazione originaria della PAC rispecchiava pertanto la necessità di ottenere al più presto risultati quantitativi. Un altro obiettivo da raggiungere attraverso la PAC, emerso nei decenni immediatamente successivi, era di mantenere un certo livello di occupazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e soprattutto assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. Non è sbagliato ritenere, quindi, che le finalità per le quali la PAC è nata rispondevano all’esigenza di costruire le basi per una maggiore coesione sociale e per un equilibrato sviluppo territoriale europeo, per tendere il più possibile al raggiungimento di simili standard tra i Paesi aderenti al progetto europeo.
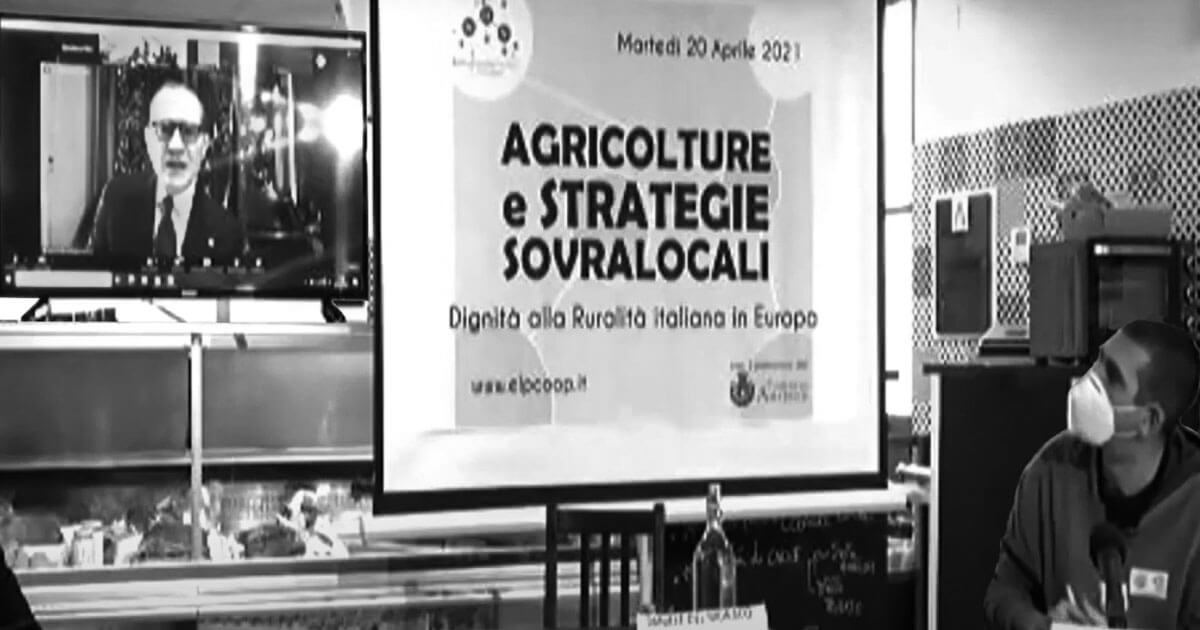
Lanciata nel 1962, la Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE ha rappresentato quindi, e rappresenta tuttora, un partenariato tra il settore agricolo e la società e tra l’Europa ed i suoi agricoltori. In agricoltura abbiamo per primi abbattuto le frontiere tra gli Stati membri, unificato i prezzi, i mercati, gli standard dei prodotti e le monete stesse. Nel corso dei decenni successivi, e dinanzi all’ampliamento della costruzione del progetto europeo mediante l’entrata di un numero sempre maggiore di Paesi europei nell’Unione, la PAC ha progressivamente iniziato a regolare in maniera molto dettagliata e specifica gli aspetti legati alla produzione e trasformazione di prodotti agricoli, alla regolazione dei mercati ed anche allo sviluppo delle zone rurali, uniformando sempre di più tali aspetti per i singoli Stati. Il ricorso all’uso dei regolamenti in materia agricola, ad esempio, è molto frequente ed elevato, segno evidente di una legislazione profondamente comune, identica per tutti gli Stati membri. Il regolamento, infatti, rappresenta uno strumento giuridico che permette di applicare direttamente il diritto unionale all’interno dei diversi quadri giuridici nazionali. L’agricoltura ha scelto l’Europa ben prima degli altri settori economici e da essa ha tratto sicuramente benefici: la gestione di un grande mercato comune, che porta anche alla standardizzazione delle regole, la delega ad un livello sovranazionale delle scelte sull’agricoltura hanno contribuito a creare una agricoltura comune ed un senso di condivisione tra gli agricoltori degli stati membri. Anche nei periodi di crisi, come quello che stiamo attraversando legato alla pandemia del COVID, o in passato, basti pensare alla crisi della BSE, l’Europa è intervenuta a tutela non solo degli agricoltori, ma anche dei consumatori e cittadini europei, con misure uniformi ed immediate identiche per tutti gli Stati e cittadini europei. Essere parte di un quadro normativo comune non vuol dire, tuttavia, perdere l’identità delle tante “agricolture” che abbiamo in Europa. Infine, la PAC è stata e rimane fondamentale per la costruzione europea anche per quanto riguarda gli aspetti di inclusione sociale ed ambientale. In merito al primo aspetto, la PAC ha permesso una grande inclusione sociale e dei lavoratori. Abbiamo visto che durante la crisi del COVID, la chiusura di alcune frontiere ha impedito a molti lavoratori di spostarsi per rendersi in altri Stati membri dove, in passato, si recavano regolarmente. Fenomeno noto a tutti gli agricoltori, ma che è emerso ed è diventato chiaro per i cittadini solo in questo periodo. L’assenza dei lavoratori “pendolari” tra Stati ha messo a rischio i raccolti ma ha dimostrato quanto questa politica sia transnazionale ed inclusiva. Anche dal punto di vista della tutela ambientale la PAC chiama ad uno sforzo comune di tutti gli agricoltori europei che, insieme, contribuiscono in modo uniforme ad una diminuzione dei gas ad effetto serra ed alla lotta ai cambiamenti climatici ed a gestire le risorse naturali in modo sostenibile. Incertezze per il futuro: in seguito alla riforma, il futuro della PAC è ancora in bilico tra la rilevanza affidata a questa politica comune, ancora al centro delle sfide dell’Unione, e un panorama di incognite e incertezze legate anche alla gestione nazionale nell’ambito di un quadro unionale.
 Si può ancora sostenere che la prossima PAC risponda agli obiettivi del Trattato? Non si può negare che nel corso degli anni è stato eroso gradualmente il plafond di risorse destinato alla politica agricola, diminuito in termini reali e in relazione alla incidenza sul totale del bilancio della UE, passando da oltre il 50% al 30%. Laddove, infatti il Trattato vede la PAC come una politica che sostiene il reddito degli agricoltori, le proposte di riforma vanno in un senso diverso. Gli agricoltori non sono più chiamati ad “incrementare la produttività” bensì a diminuirla, a scapito della fornitura di servizi ambientali. Tutto questo mentre aumenta l’attenzione a livello globale per le tematiche della food security e la consapevolezza, anche dopo la pandemia del Covid-19, della strategicità di un autoapprovvigionamento sufficiente e di una compagine di imprese agricole che abbiano sufficiente fiducia per continuare ad operare in uno scenario sempre più complesso tra minacce del cambiamento climatico e volatilità dei mercati. La diminuzione della produzione ed i sempre più elevati standard produttivi cui sono chiamati gli agricoltori, potrebbero anche far venir meno l’ultimo obiettivo del Trattato, vale a dire garantire prezzi equi per i consumatori che potranno dover pagare, come contribuenti e come consumatori, prodotti qualitativamente ma non quantitativamente sufficienti, aprendo la porta ad importazioni da paesi terzi che non rispecchiano gli stessi standard qualitativi ed ambientali dell’Europa.
Si può ancora sostenere che la prossima PAC risponda agli obiettivi del Trattato? Non si può negare che nel corso degli anni è stato eroso gradualmente il plafond di risorse destinato alla politica agricola, diminuito in termini reali e in relazione alla incidenza sul totale del bilancio della UE, passando da oltre il 50% al 30%. Laddove, infatti il Trattato vede la PAC come una politica che sostiene il reddito degli agricoltori, le proposte di riforma vanno in un senso diverso. Gli agricoltori non sono più chiamati ad “incrementare la produttività” bensì a diminuirla, a scapito della fornitura di servizi ambientali. Tutto questo mentre aumenta l’attenzione a livello globale per le tematiche della food security e la consapevolezza, anche dopo la pandemia del Covid-19, della strategicità di un autoapprovvigionamento sufficiente e di una compagine di imprese agricole che abbiano sufficiente fiducia per continuare ad operare in uno scenario sempre più complesso tra minacce del cambiamento climatico e volatilità dei mercati. La diminuzione della produzione ed i sempre più elevati standard produttivi cui sono chiamati gli agricoltori, potrebbero anche far venir meno l’ultimo obiettivo del Trattato, vale a dire garantire prezzi equi per i consumatori che potranno dover pagare, come contribuenti e come consumatori, prodotti qualitativamente ma non quantitativamente sufficienti, aprendo la porta ad importazioni da paesi terzi che non rispecchiano gli stessi standard qualitativi ed ambientali dell’Europa.
In sostanza ci si deve interrogare se la riforma e le strategie del Green Deal non modificheranno l’unica politica veramente unionale della UE incidendo in modo sostanziale anche sulla grande idea di un “mercato comune dell’agricoltura e dei prodotti agricoli” prevista dai fondatori dell’Europa.
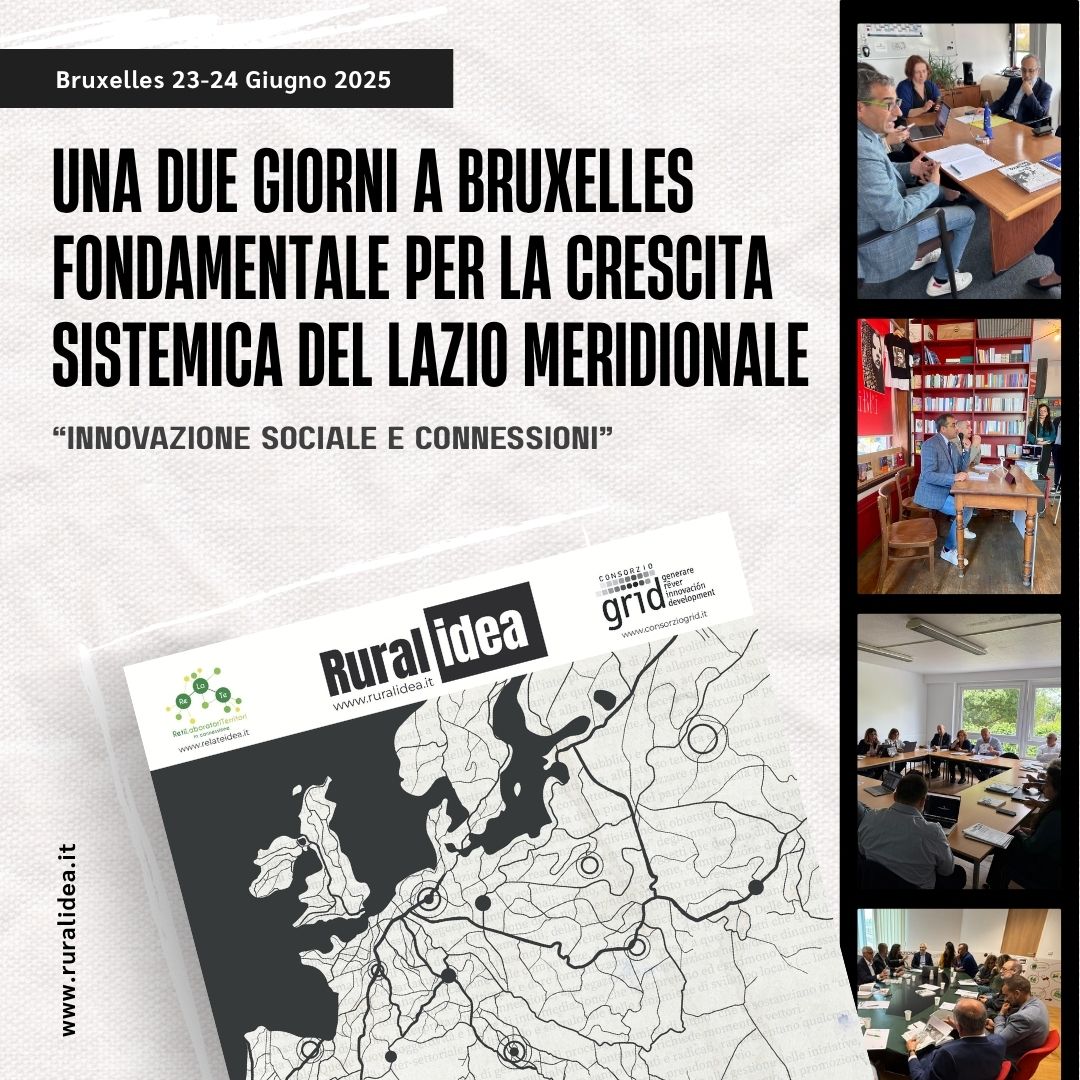





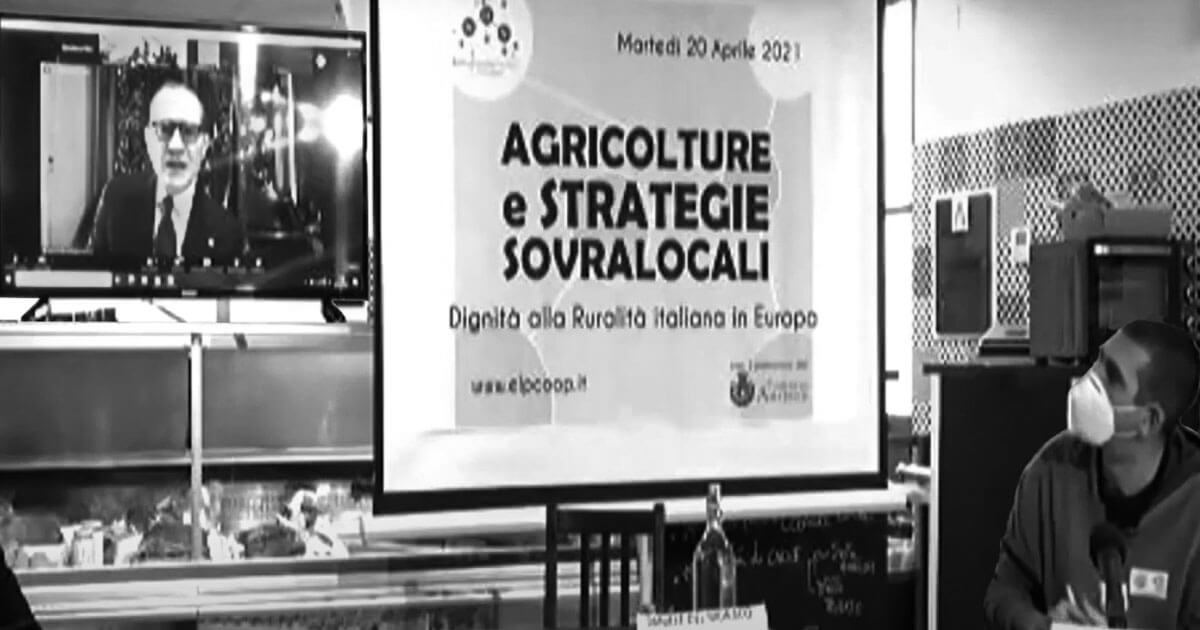
 Si può ancora sostenere che la prossima PAC risponda agli obiettivi del Trattato? Non si può negare che nel corso degli anni è stato eroso gradualmente il plafond di risorse destinato alla politica agricola, diminuito in termini reali e in relazione alla incidenza sul totale del bilancio della UE, passando da oltre il 50% al 30%. Laddove, infatti il Trattato vede la PAC come una politica che sostiene il reddito degli agricoltori, le proposte di riforma vanno in un senso diverso. Gli agricoltori non sono più chiamati ad “incrementare la produttività” bensì a diminuirla, a scapito della fornitura di servizi ambientali. Tutto questo mentre aumenta l’attenzione a livello globale per le tematiche della food security e la consapevolezza, anche dopo la pandemia del Covid-19, della strategicità di un autoapprovvigionamento sufficiente e di una compagine di imprese agricole che abbiano sufficiente fiducia per continuare ad operare in uno scenario sempre più complesso tra minacce del cambiamento climatico e volatilità dei mercati. La diminuzione della produzione ed i sempre più elevati standard produttivi cui sono chiamati gli agricoltori, potrebbero anche far venir meno l’ultimo obiettivo del Trattato, vale a dire garantire prezzi equi per i consumatori che potranno dover pagare, come contribuenti e come consumatori, prodotti qualitativamente ma non quantitativamente sufficienti, aprendo la porta ad importazioni da paesi terzi che non rispecchiano gli stessi standard qualitativi ed ambientali dell’Europa.
Si può ancora sostenere che la prossima PAC risponda agli obiettivi del Trattato? Non si può negare che nel corso degli anni è stato eroso gradualmente il plafond di risorse destinato alla politica agricola, diminuito in termini reali e in relazione alla incidenza sul totale del bilancio della UE, passando da oltre il 50% al 30%. Laddove, infatti il Trattato vede la PAC come una politica che sostiene il reddito degli agricoltori, le proposte di riforma vanno in un senso diverso. Gli agricoltori non sono più chiamati ad “incrementare la produttività” bensì a diminuirla, a scapito della fornitura di servizi ambientali. Tutto questo mentre aumenta l’attenzione a livello globale per le tematiche della food security e la consapevolezza, anche dopo la pandemia del Covid-19, della strategicità di un autoapprovvigionamento sufficiente e di una compagine di imprese agricole che abbiano sufficiente fiducia per continuare ad operare in uno scenario sempre più complesso tra minacce del cambiamento climatico e volatilità dei mercati. La diminuzione della produzione ed i sempre più elevati standard produttivi cui sono chiamati gli agricoltori, potrebbero anche far venir meno l’ultimo obiettivo del Trattato, vale a dire garantire prezzi equi per i consumatori che potranno dover pagare, come contribuenti e come consumatori, prodotti qualitativamente ma non quantitativamente sufficienti, aprendo la porta ad importazioni da paesi terzi che non rispecchiano gli stessi standard qualitativi ed ambientali dell’Europa.